
INVIDIA . Lector In Invidia
Prima dell’ultimo canto del cigno
In 22 Novembre 2018 da Attilia Patri DP
Pompei. Scavi inseriti nel Grande Progetto Pompei. Zona Regio V. Via del Vesuvio. Una Domus. Un ingresso, le fauces. Un atrium, la stanza centrale. Un cubicolo, la camera da letto, e qui, su un muro, c’è lei, Leda.
Leda che emana un impatto visivo da togliere il fiato con quella rappresentazione unica e particolare, un’iconografia sensuale, esplicita, senza sottintesi, come mai trovata prima in altri affreschi. È là, immobile scena vibrante, quasi sfacciata e ammiccante, con il morbido braccio sollevato a reggere un drappo della veste dorata di regina come a proteggersi da uno sguardo troppo insistente. È là, e sembra fissare lo spettatore, immortalata su sfondo rosso con l’impetuosa bellezza di giovane donna sottolineata da un uso sapiente di tutta la gamma dei rosa a definire contorni, ombre, luci, pieghe cutanee e, tra le pieghe più intime, tutte le gradazioni del bianco e del ceruleo a rappresentare la maestosità del Cigno.Trapela e trionfa con una fattura di altissima qualità, con una bellezza che sa di cultura antica, un riferimento alla Leda del greco Timoteo, grande scultore del IV secolo a.C., con un tripudio di colori ancora vividi e magnifici, intatti come se fossero stati dipinti ieri, e che la furia della lava ha risparmiato, facendocene dono.
Leda e il Cigno. Il mito e la leggenda tratto da Le metamorfosi di Ovidio è lì, su sfondo rosso, su un muro che racconta quella storia di Leda, bellissima regina moglie del re Tindaro di Sparta, e di Giove, re degli dei, che, pur di averla e di sedurla, si trasformò in un meraviglioso cigno bianco. È il racconto, pervaso di ambrosia stordente, del potere dell’erotismo, della sensualità dell’amore fisico, della forza della seduzione, della trasformazione per ordire l’inganno, della tensione tra amore e violenza mascherata in qualcosa di candido e insospettabile, della crudeltà nascosta dalla parvenza di innocenza.
Dall’amplesso si formarono due uova che portarono alla luce i Dioscuri, Castore e Polluce, ma anche la bella Elena nel cui nome si scatenò la guerra di Troia e Clitemnestra, sposa e assassina di Agamennone.
La leggenda ha rapito nei secoli l’attenzione e l’interesse di artisti e scultori, da Leonardo a Michelangelo, e fu un tema molto in voga nel mondo artistico del Rinascimento quando sarebbe stato assolutamente impossibile raffigurare scene erotiche tra un uomo e una donna mentre era possibile alludervi, attraverso la letteratura e il mito, del quale solo alcune persone conoscevano il senso.
Troviamo opere dedicate un po’ ovunque: basta uscire e andare per musei e per palazzi come a Firenze, al Palazzo del Bargello con la scultura in marmo bianco di Carrara riferita all’Ammannati, o le tavole di studio di Leonardo della testa di Leda tra gli Uffizi e il Castello Sforzesco di Milano, o i Musei Capitolini con la scultura datata all’età adrianea della copia dell’originale dello scultore Timotheos (360 a.C.) o a Berlino presso la Gemäldegalerie per ammirare la tela 152 per 191 centimetri di Correggio.
Anche la Chiesa cattolica si interessò al mito manipolandolo, e volendo vedere in Leda l’immagine del candore di Maria e nel cigno il simbolo dello Spirito Santo che, con la sua candida purezza, scendeva sulla prediletta tra le donne.
 E torniamo a quel muro e a quella Leda specifica, arrivata a noi, e che noi ammiriamo ammutoliti mentre lei, con sguardo di scambio verso di noi, si starà chiedendo quale sarà la sua fine ultima, la sua preservazione ora che è tornata a nuova vita scoperchiando il buio.
E torniamo a quel muro e a quella Leda specifica, arrivata a noi, e che noi ammiriamo ammutoliti mentre lei, con sguardo di scambio verso di noi, si starà chiedendo quale sarà la sua fine ultima, la sua preservazione ora che è tornata a nuova vita scoperchiando il buio.
Adesso, a Leda, dobbiamo delle risposte, ma le risposte sottintendono domande. Domande spesso scomode.
Siamo sempre noi, noi che gioiamo per Pompei, per quella Pompei spesso trascurata, vie notturne, e non solo, indisturbate per branchi di cani randagi, colonne che cedono sotto i colpi di pioggia neanche tanto insistenti, siamo sempre noi il Paese dall’immenso patrimonio paesaggistico, storico, culturale e artistico; quelli che per secoli furono fulcro della civiltà sotto ogni punto di vista, polo culturale e finanziario per l’elite europea rinascimentale, e ancora, nel Seicento, richiamo di dotti nella stagione del Grand Tour effettuato dai ricchi giovani dell’aristocrazia europea con lo scopo di perfezionare il loro sapere e di tanti cultori celebri della Penisola? Resta qualcosa di quei noi di ieri oppure l’Italia contemporanea, e con lei i noi di oggi, sta attraversando un periodo di decadenza, una sorta di imbruttimento generale che intacca tutto, una lava non nera come quella di Pompei, ma piuttosto una lava di indifferenza che offusca un passato glorioso e offusca, appannando, un possibile risveglio, un possibile altro da questo torpore? Siamo consci di avere un patrimonio paesaggistico e culturale dal valore inestimabile che si sta sgretolando, giorno dopo giorno, per incuria?
Basta girare in una qualsiasi città italiana e ci si può accorgere di come qualche monumento, qualche opera d’arte o architettonica sia martire del degrado se non della completa dimenticanza ed è inutile cercare un colpevole perché ne esistono quasi sempre più di uno, spesso vittime di cause di forza maggiore, prima di tutte la cronica mancanza di fondi pubblici da destinare ai beni culturali, seguita dall’averli messi troppe volte in secondo piano come beni di categoria inferiore perché, in un Paese in crisi, i problemi sono sempre ben altri rispetto alla salvaguardia di quelli ritenuti di serie b, l’aver a volte sposato la tesi che di cultura non si vive; senza contare la burocrazia avviluppante e stagnante che imbriglia la volontà di intervento, quando c’è, dei privati.
 Conti alla mano, in Italia, nel 1955 andava in cultura lo 0,80% del Pil, oggi ne viene investito solo lo 0,19% e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: l’incuria in cui versa il centro storico di Roma e non solo, la scarsa valorizzazione e le problematiche di sicurezza, conservazione, accessibilità di musei importanti in città altrettanto importanti, la non sufficiente cura della Reggia di Caserta, dei suoi parchi, acquedotto compreso, un monumento al declino nonostante la sua grandiosità, la dimenticata importanza dei Bronzi di Riace, gli archivi percepiti solo come luoghi polverosi elitari di raccolta di testimonianze, il contenuto di prestigiose biblioteche lasciato in pasto alle tarme, e si potrebbe andare avanti riempendo pagine di elenchi,
Conti alla mano, in Italia, nel 1955 andava in cultura lo 0,80% del Pil, oggi ne viene investito solo lo 0,19% e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: l’incuria in cui versa il centro storico di Roma e non solo, la scarsa valorizzazione e le problematiche di sicurezza, conservazione, accessibilità di musei importanti in città altrettanto importanti, la non sufficiente cura della Reggia di Caserta, dei suoi parchi, acquedotto compreso, un monumento al declino nonostante la sua grandiosità, la dimenticata importanza dei Bronzi di Riace, gli archivi percepiti solo come luoghi polverosi elitari di raccolta di testimonianze, il contenuto di prestigiose biblioteche lasciato in pasto alle tarme, e si potrebbe andare avanti riempendo pagine di elenchi,
Eppure l’Italia della bellezza, della qualità, dell’arte, produce una ricchezza pari a oltre settantacinque miliardi di euro l’anno e, sommando l’indotto del turismo legato alle città d’arte, produce oltre il quindici per cento dell’economia nazionale. Di fatto un buon motore per far cassa ma che andrebbe migliorato applicando due parole quasi magiche: prevenzione e restauro. Prevenzione e restauro al pari di voglio la pace nel mondo: impossibile. Impossibile pur non mancando gli esempi virtuosi di patrimonio artistico recuperato come Venaria Reale, residenza sabauda in Piemonte o il recupero dei Sassi di Matera, da vergogna italiana a punto di forza di una città insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura 2019.
Se da una parte il turismo e il consumo d’arte va incentivato, dall’altra, in alcune città, non si riesce più a reggere la massificazione dei visitatori e, soprattutto, non si riesce ad arginare, e tentare di azzerare, la maleducazione, la volgarità, l’offesa dei monumenti e del decoro urbano. Se alla perdita di civiltà delle persone si sommano i danni provocati da situazioni ambientali e climatiche a volte ostili o le grandi e piccole catastrofi che il nostro territorio periodicamente elargisce, si può facilmente intuire come ci si trovi sempre più in bilico verso un tracollo generale del magnetismo indiscusso che il nostro Paese esercitava sul turista estero solo fino a pochi anni fa. Per rimanere ancora Bel Paese, per essere ricordati per le rovine antiche e non per le rovine attuali, occorre risalire ma, ancora prima di risalire, occorre arrestare la caduta, mettere in atto strategie mirate di collaborazione fattiva tra Comuni, Regioni, Governo, Associazioni. È necessario risvegliarsi da questo torpore, dare priorità con carattere d’urgenza agli interventi, scrollarsi di dosso la mala gestione, allontanare il fantasma di un’Italia artistica figlia dell’indifferenza ogni volta che un affresco si sgretola nel silenzio, una colonna o un capitello crollano senza che nessuno si sia mai accorto del loro stato di precarietà svettante, una chiesa antica viene vandalizzata o si lascia che le fontane vengano assurte a latrine a cielo aperto e i templi incustoditi diventino luogo di bivacco, di siringhe e spazzatura lasciata lì per comodo. Siamo il Paese che detiene il più alto numero in assoluto di siti Unesco, ben 49, eppure lasciamo alla criminalità la gestione di molti altri luoghi monumentali più trascurati e dove, indisturbati, vanno in scena, quotidianamente, lo spaccio, lo smercio di roba contraffatta, il controllo abusivo del territorio, tra l’indifferenza di chi sa ma è sufficiente non passare di lì e, se proprio si deve, girare la testa dall’altra parte. Tutela e valorizzazione adeguate se si vuole preservare un’eredità comune di grandezza e valore storico-artistico inestimabile e non generare ulteriormente un indesiderato accollo per le generazioni più giovani. Se le istituzioni economicamente non possono far fronte al decadimento ben vengano allora i privati o le multinazionali, moderni mecenati in grado di finanziare i lavori di restauro dietro ai grandi pannelli pubblicitari.
 Il patrimonio artistico e culturale italiano non è solo un affare Made in Italy, da Palazzo, ma piuttosto una carta di identità, di appartenenza di un popolo, una certificazione di ricchezza e, come ogni ricchezza, si può gestire o sperperare o ignorare, o tradire e stuprare. Cominciamo con il pretendere e l’esercitare il rispetto verso le nostre opere tutte, verso i nostri centri, facciamone dei salotti buoni, potenziamo i controlli, applichiamo sanzioni, e che nessuno di noi, tornando da un Paese estero, abbia a dire: “Eh ma là non si scherza! Tutto pulito, ordinato, i giardini curati, non vedevi neanche un mozzicone buttato per strada, un pezzetto di carta; un’attenzione al turista ineccepibile, file ordinate e cinquanta controlli per entrare in musei accoglienti…”.
Il patrimonio artistico e culturale italiano non è solo un affare Made in Italy, da Palazzo, ma piuttosto una carta di identità, di appartenenza di un popolo, una certificazione di ricchezza e, come ogni ricchezza, si può gestire o sperperare o ignorare, o tradire e stuprare. Cominciamo con il pretendere e l’esercitare il rispetto verso le nostre opere tutte, verso i nostri centri, facciamone dei salotti buoni, potenziamo i controlli, applichiamo sanzioni, e che nessuno di noi, tornando da un Paese estero, abbia a dire: “Eh ma là non si scherza! Tutto pulito, ordinato, i giardini curati, non vedevi neanche un mozzicone buttato per strada, un pezzetto di carta; un’attenzione al turista ineccepibile, file ordinate e cinquanta controlli per entrare in musei accoglienti…”.
Cominciamo a non scherzare più neanche qua. Cominciamo a essere veramente gelosi in senso positivo della “nostra roba”, smettiamola con il tradimento a oltranza, subito, prima che qualche capolavoro suoni, agonizzante, il suo ultimo canto del cigno.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
La Costituzione, art. 9
Navigazione
Consigli
Articoli recenti
- Lo sbarco di Anzio dal vivo 19 Aprile 2024
- Armando Testa 12 Aprile 2024
- Fantasia! 9 Aprile 2024
- Storie d’amore 2 Aprile 2024
- Dipingendo te 31 Marzo 2024

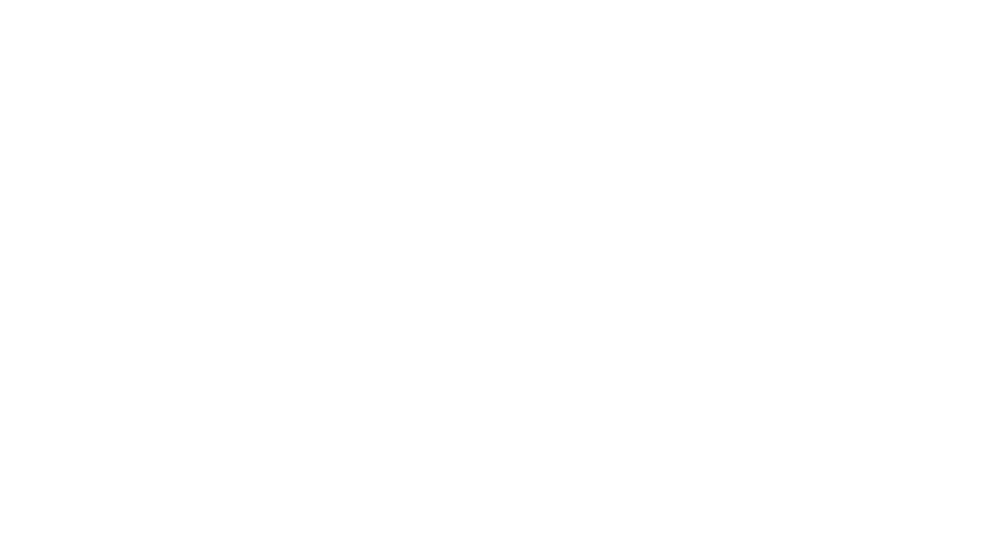
Lascia un commento