
IRA . Racconti da Kepler




La battaglia di Pavia
In 24 Febbraio 2017 da Il ViaggiatoreDiario del Viaggiatore.

Battle of Pavia, Museum of Art di Birmingham
21 febbraio 2017, ore 10 del mattino.
Il mio viaggia inizia qui, in Alabama, al Museum of Art di Birmingham. Devo farmi un’idea e qui c’è un quadro che mi può aiutare. La battaglia sembra furibonda. L’artista di questo olio su tela è sconosciuto.

La battaglia di Pavia, Ruprecht Heller, Nationalmuseum Stoccolma.
22 febbraio 2017, ore 12
Stoccolma Nationalmuseum. Il fiume, la prima cinta muraria, la seconda. Non c’è il Ponte. Una casa tra le due cinta. Cannoni, insegne. L’olio su tela è di Ruprecht Heller.
22 febbraio 2017, ore 13.

The battle of Pavia, artista sconosciuto, Royal Armouries, Leeds
Leeds, Yorkshire e Humber, Inghilterra. Sono al Royal Armouries: qui vedo accampamenti con le tende e battaglia soprattutto con lance. Il fiume e il ponte. Informazioni utili.

Battaglia di Pavia, museo di Capodimonte
22 febbraio 2017, ore 15
Napoli, museo di Capodimonte. I sei arazzi di questa sala raccontano la battaglia e mi danno una ricostruzione sommaria della città. Interessante, utile. Verificare le torri e le porte principali.

Immagine dall’arazzo; modello 3D di Alessandro Gatti e Simone Guasconi; stampa 3D ottenuta con Sharebot NG PLA). Università degli studi di Pavia
22 febbraio 2017, ore 18
Università di Pavia: ricostruzione della città in 3D. Utili indicazioni su come muoversi all’interno delle vie. Itinerario da visitare completato.
Credo di non aver studiato così tanto prima di un viaggio per ripercorrere la vostra storia. Mi devo muovere.
23 febbraio 1525, ore 16
Attraverso il Ponte, qui lo chiamano vecchio. In realtà ha poco più di cento anni, quello vecchio è caduto diversi secoli fa. Lo avevano costruito i romani e quando ci sono le secche affiorano i basamenti in pietra e travi in legno conficcate sul fondale. Il Ticino scorre sotto di me: mi giro verso destra e riesco a malapena a intravedere il fiume che curva verso il Po accarezzando le rive. Che freddo in questa Pavia. Sono entrato dalla porta di ingresso, quella del Borgo con un lasciapassare da commerciante spagnolo e le guardie dalla risata sguaiata e maleodorante non hanno obiettato. Sono ormai a metà del ponte e l’odore del fiume si fa pungente, come è pungente il vento laterale intriso di nebbia e pioggia leggera che fa persino lacrimare gli occhi e inumidire la barba che mi sono fatto crescere per l’occasione. Mi chiamo ancora Gonzalo Ribargoza, come avevo fatto a Napoli durante l’eruzione del Vesuvio del 1631. Pochi viandanti: un carretto spinto da due bambini vestiti di stracci, un ragazzotto dagli occhi azzurri tristi e rassegnati con una fascina di legno sulla spalla destra. Sotto ci sono dieci arcate meravigliose. Questo ponte è un vero gioiello architettonico che purtroppo andrà perduto per i bombardamenti della Seconda guerra mondiale: le bellezze artistiche non vengono distrutte solo nei vostri tempi. Il pavimento di pietra è lucido, capirai con questa nebbia come non potrebbe esserlo… ma come faranno gli abitanti a sopportarla? Di sicuro la odiano i francesi che assediano e hanno i piedi nell’umido: imprecano e muoiono soffocati perché i polmoni e i bronchi non resistono a questo clima e si riempiono di catarro. Intanto sono arrivato all’altra porta Ticino, quella che mi permette di entrare dentro le mura. “Chi va là!” mi dice la guardia. Lo dice con un accento quasi francese e immagino che il dialetto locale gli somigli fin troppo. La città è stata fondata dai Marici, una tribù ligure, poi arrivarono i romani con il loro castrum, poi i barbari fino ai Longobardi che qui ci fissarono pure la Capitale del Regno d’Italia. Poi la caduta in mano ai francesi e poi in quelle degli spagnoli: da queste parti devono essere abituati a chi arriva, depreda, la fa da padrone in attesa di essere sostituito da un altro. La città, vi dicevo, è sotto assedio ma l’epilogo si avvicina. Mancano poche ore. Cambieranno per l’ennesima volta le sorti dell’Europa. Intanto passo anche da qui: stesso copione, stesse risate maleodoranti con la differenza che una fanciulla del luogo con lunghi capelli biondi e dalle mani rosse per il gelo con una cesta di panni lavati al fiume troppo pesante, li distrae non certo contenta di questo; e così, senza aggiungere molto, riesco a entrare. Dopo le mura spagnole ho varcato quelle medioevali. Sono dentro la città e devo dire che è affascinante: se alzo lo sguardo vedo tantissime torri, qualcuna persino parzialmente coperta dalla nebbia. Pavia la chiamano la città delle cento torri e hanno ragione. Intanto sono risalito di un pezzo di questa Strada Nova, questo il nome della contrada che, nella costruzione degli antichi romani sarebbe il cardo maximus. Case vecchie, povertà da assedio, soldati ovunque e lingue diverse, dallo spagnolo a un idioma simile al tedesco, devono essere i Lanzichenecchi svizzeri. E poi anche italiani di altre zone, sono altri mercenari. Conosco questa città e vederla adesso, così indietro nei tempi è un’emozione grandissima. Mi avvicino ai muri, rossi, tutti di mattoni a vista spesso sporchi di fuligine. Chiasso, carretti, bettole, botteghe di artigiani, fumo acre e odore di pellame lavorato. Ogni tanto, per pulire la strada aprono un ramo di una roggia che si chiama Carona. Ci vorrebbe anche adesso.
Voglio andare verso il Castello dei Visconti, del resto non è lontano. Sulla sinistra c’è la contrada del mercato, la prima delle cinque che compongono la parte di sinistra del decumanus maximus, quello parallelo al fiume. Subito dopo questa breve contrada si apre il forum, Piazza grande, aperta quasi due secoli fa e dove si trova il Broletto. So che diventerà famosa in una vostra canzone del 1971. Il Duomo, invece, non ha la cupola ma svetta la torre comunale, quella caduta nel 1989.
Se guardi in alto vedi un cielo bianco di morte che pian piano conosce il primo buio serale, se abbassi lo sguardo vedi fame, ovunque, perché quando ci sono viveri, questi vengono requisiti e resta ben poco: non è la guerra ma la dominazione feroce a farla da padrona. Le uova sono preziose, una gallina un bene di lusso. Ci sono 20 mila tra spagnoli, italiani mercenari, lanzichenecchi reclutati ovunque sotto le insegne del Sacro romano impero di Carlo V d’Asburgo e guidata sul campo da Carlo di Lannoy, viceré di Napoli, da Carlo di Borbone e di Ferdinando d’Avalos, Marchese di Pescara dentro la città; quasi 30 mila tra francesi e altri lanzichenecchi capeggiati da Francesco I accampati fuori Pavia. Ogni tanto bombarde e cannoni fan volare palle di metallo e abbattono pezzi di mura, chiese e case e poco importa se qualcuno ci muore. Milano l’anno scorso si è arresa subito, qui non ci pensano nemmeno. Borbottano e non danno confidenza, sono chiusi e fatalisti o meglio abituati a quel finto stupore per cui quando ti capita qualcosa fingi di non sapere che sarebbe andata così.
Sulla destra c’è l’Università, antica, in crisi per la guerra. Non ci posso nemmeno entrare perché occupata dalle truppe. Mi perdo in una contrada laterale: finestre a volta, facce scure, cavalieri con archibugi, qui li useranno per la prima volta e risulteranno decisivi, e cavalli, che fanno risuonare i sassi delle strade e lasciano letame che è difficile non calpestare. Le armi sono ancora le lance e le borgogne ma la polvere da sparo sta diventando sempre di più decisiva e utilizzata. Da una bettola esce un ubriaco, spintonato da due mercenari che non sanno come ingannare il tempo. Più avanti un bordello: un soldato si sistema i calzoni uscendo dalla porta. Un altro entra percorrendo al contrario la scala.
Fuori stanno per cambiare gli equilibri d’Europa e succederà proprio qui, anzi qualche chilometro più a nord, nel parco del Castello che arriva fino alla Certosa. Castello vi dicevo: una meraviglia, con le quattro torri e non le due rimaste oggi. Il fossato con il suo ponte levatoio abbassato infondono senso di forza ma sono sinonimi di tempi bui e non di cultura di quando Francesco Petrarca organizzava in una torre la biblioteca dei Visconti e in un altro le dame si preparavano per le feste. Leggenda narra che in qualche muro interno sia stato murato un certo Pasquino Cappelli, il cancelliere di Galeazzo II Visconti, che evidentemente non era molto soddisfatto del suo lavoro. In tempi migliori si spaventano i bambini con questa storia, a volte gli adulti lo augurano a quello con cui hanno una discussione. Mi giro e vedo la torre dove è stato incarcerato il filosofo Severino Boezio: immagino il freddo che potesse fare lassù quando il re Teodorico lo imprigionò in attesa del processo e della condanna a morte. Torno indietro e scendo verso sud: so che esiste una torre stranissima in contrada San Romano, la chiamano del Pizzo in giù. Eccola! Ha una particolarità architettonica: è più stretta alla base e, come dice il nome, è come se fosse rovesciata. Una cosa unica eretta il secolo scorso e che gli spagnoli faranno abbattere tra due secoli, inserendosi nell’elenco di chi farà scempio di questa città.
Ma scendo ancora in queste contrade che ti fanno camminare sui sassi e ti lasciano sul fianco i muri tutti rossi: toccandoli è come se percepissi la storia che li hanno visti testimoni silenziosi e imponenti. Più giù c’è un’altra porta, quella chiamata di San Giovanni: qui Re Alboino entrò in città alla guida dei suoi Longobardi alla vigilia della Pasqua del 572 dopo tre anni di assedio. Voleva vendicarsi dei cittadini e pretese pure 12 vergini. I pavesi invece lo accolsero con ramoscelli di ulivo e un fornaio con un dolce che prese il nome di sua figlia: Colomba, pare una delle 12 fanciulle richieste. Sì, la colomba, l’hanno inventata qui. Non si sa se le vergini la passarono veramente liscia, di sicuro c’è che ai barbari piacque talmente tanto il dolce (ma soprattutto apprezzarono la posizione strategica della città) che ne fecero la loro capitale del loro Regno e poi di quello d’Italia.
Si è fatto buio e le strade sembrano essere meno sicure, in giro ci trovi solo soldati, sembra che si stiano radunando. I pavesi sono nelle case, semibuie. Percorro una contrada con un nome che dice già tutto: Stretta Lunga. Poi diventerà degli Unni. Questa strada ha una particolarità: solo a metà ne vedi la fine, perché è leggermente a elle. Conduce a porta Salara, quella appunto dove entra il sale trasportato sul fiume. I muri hanno il muschio, qui il sole non si vede mai. Sulla destra c’è una locanda ed entro. Odore, fumo dal camino, vino nei boccali e diversi energumeni che ridono e cantano in tedesco. Un cane si gode il caldo del camino, qualcuno gioca ai dadi e si intravedono i coltelli conficcati sotto il tavolo. Nessuno mi degna di uno sguardo. L’oste sdentato e dalle unghie sporche mi chiede cosa voglio e mi porta una caraffa di vino. Butto lì qualche moneta, che l’uomo raccoglie senza nemmeno ringraziare. Ascolto di battaglie, di donne, di francesi insultati e derisi. Sono più delle 10, la resa dei conti si avvicina. Sento addosso la puzza di questo posto, ho pure finto di bere. Esco e mi avvio verso il fiume. Questa strada, così particolare, la trovo metafora della vita: quando giungi a metà non vedi l’inizio ma intravedi la fine che pian piano si avvicina. Arrivo vicino alla Porta e sento l’odore del fiume e immagino il suo scorrere lento. Più a nord, nel castello di Mirabello, la battaglia finale è all’inizio: con la sconfitta dei francesi l’Italia settentrionale cambia padrone, la storia europea sta per scrivere un altro episodio, un Re sta per essere fatto prigioniero e un contadino tra qualche ora gli preparerà una zuppa destinata ad arrivare fino alla corte di Parigi e al Castello des Tournelles.
Alla prossima.
Navigazione
Consigli
Articoli recenti
- Il Sandwich bologna che a Yale è proibito 24 Luglio 2024
- Mille volte ancora 23 Luglio 2024
- Quella parte che manca 21 Luglio 2024
- Bar Stories on Camera 18 Luglio 2024
- Riflessi 9 Luglio 2024


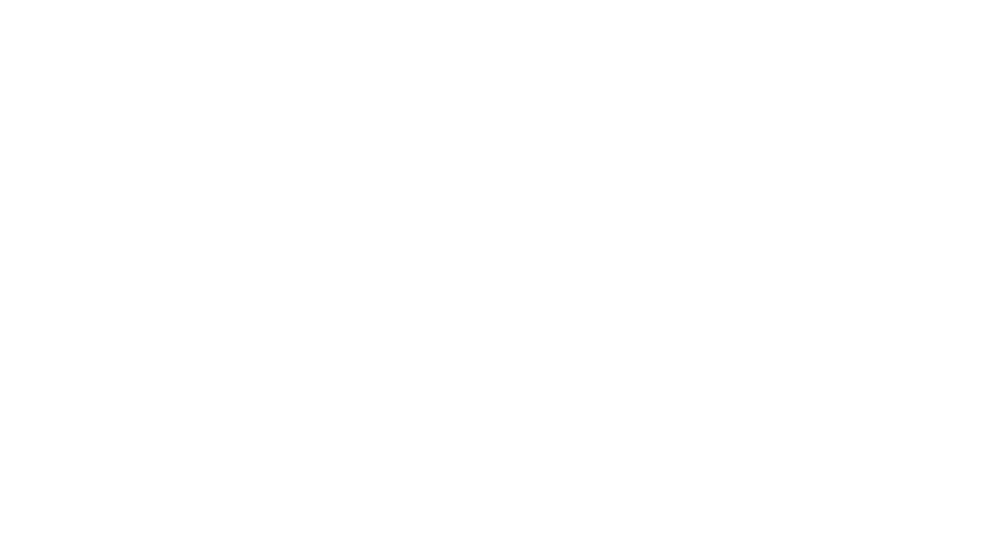
Lascia un commento